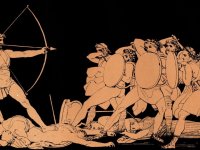Prima di Oppenheimer e dopo i sogni labirintici di Inception, Christopher Nolan firmò un film di guerra che sembrava tutto tranne che convenzionale. Dunkirk non parla della vittoria, ma della sopravvivenza. Non racconta il conflitto, ma il tempo - e per Nolan, fu il suo esperimento più radicale.
L'esperimento di Nolan: la guerra come percezione del tempo
Nel 2017 Christopher Nolan decise di raccontare la Seconda guerra mondiale senza sangue, eroi o retorica. Dunkirk è un film che frantuma la cronologia, sfida la narrativa e trasforma la battaglia in un'esperienza sensoriale. Lo stesso regista lo definisce "il mio film più sperimentale dai tempi di Memento", spiegando a Time che l'obiettivo non era costruire un enigma, ma "un'esperienza che travolge lo spettatore".

L'idea nasce da una delle pagine più cupe della storia britannica: nel 1940, oltre 340.000 soldati inglesi furono intrappolati sulla spiaggia di Dunkerque, accerchiati dai tedeschi. Invece di filmare lo scontro frontale, Nolan preferì rappresentare l'attesa, la paura, il rumore costante del tempo che scorre. Come in Memento, anche qui la struttura è frammentata: tre linee temporali - terra, mare e cielo - che si intrecciano in un crescendo di tensione. Il mare è un giorno, la terra una settimana, il cielo un'ora: tre durate che si muovono a ritmi diversi ma destinati a convergere nello stesso istante, quando la salvezza diventa possibile.
Girato in pellicola IMAX 70mm e con pochissimi effetti digitali, Dunkirk è un monumento alla fisicità del cinema: Nolan ha rigirato realmente nel porto francese, utilizzando navi, aerei e vere tempeste. È un film dove il suono di Hans Zimmer - scandito da un orologio che non smette mai di ticchettare - diventa il vero protagonista. "Non voglio che il pubblico pensi al film in modo cerebrale," disse Nolan. "Non è un puzzle. È un viaggio." E come ogni viaggio, anche Dunkirk lascia il pubblico stordito, esausto, ma in qualche modo redento.
Un film sottovalutato che anticipa "Oppenheimer"
Nonostante i premi e gli elogi della critica, Dunkirk rimane uno dei film più sottovalutati del regista britannico. Forse perché non ha la complessità concettuale di Inception o la densità emotiva di Interstellar, o forse perché - come Memento - non offre risposte immediate. Eppure, in retrospettiva, è il film che più di ogni altro anticipa Oppenheimer: la guerra interiore dell'uomo di fronte al proprio genio distruttivo.

Con Dunkirk, Nolan costruisce una sinfonia visiva sulla sopravvivenza collettiva. Non c'è un protagonista unico, ma frammenti di umanità - un pilota (interpretato da Tom Hardy, quasi sempre con il volto coperto), un giovane soldato terrorizzato (Fionn Whitehead), un civile coraggioso (Mark Rylance) - che si muovono come ingranaggi di un orologio impazzito. È un film dove l'eroismo si misura nel silenzio, non nelle parole; nella capacità di restare vivi, non di vincere.
Il regista realizzò il film "con l'orgoglio di un britannico e la libertà di un autore hollywoodiano", riuscendo a rendere universale una storia che appartiene al DNA del suo Paese. E oggi, rivederlo in streaming su Peacock (dopo anni di assenza dalle piattaforme) significa riscoprire la sua purezza cinematografica: un film che parla poco ma dice tutto, che usa la guerra non per intrattenere, ma per ricordare.
Con Dunkirk, Nolan ci ha mostrato che la sopravvivenza può essere poetica e il tempo - ancora una volta - il suo protagonista più crudele.