Film come sogno, film come musica. Nessun'altra arte come il cinema va direttamente ai nostri sentimenti, allo spazio crepuscolare nel profondo della nostra anima, sfiorando soltanto la nostra coscienza diurna. Un nulla del nostro nervo ottico, uno shock: ventiquattro quadratini illuminati al secondo, e tra di essi il buio.

Nella scena probabilmente più famosa di Io e Annie, Alvy e Annie vorrebbero andare al cinema a vedere L'immagine allo specchio di Ingmar Bergman; Annie, tuttavia, arriva in ritardo all'appuntamento, e quindi Alvy, in preda a una delle sue idiosincrasie perché il film è già iniziato, decide di ripiegare su Il dolore e la pietà. In Manhattan invece Mary, l'intellettuale snob sempre interpretata da Diane Keaton, inserisce Ingmar Bergman nella cosiddetta "accademia dei sopravvalutati", scatenando la replica stizzita di Isaac ("È l'unico genio del cinema dei nostri giorni"); ma la donna prosegue imperterrita, imputando a Bergman di essere "così scandinavo" e di voler "tentare di nobilitare le vostre inibizioni psicologiche e sessuali collegandole a fondamentali questioni filosofiche".
Leggi anche: Io e Annie: la vita e l'amore secondo Woody Allen in sette scene cult
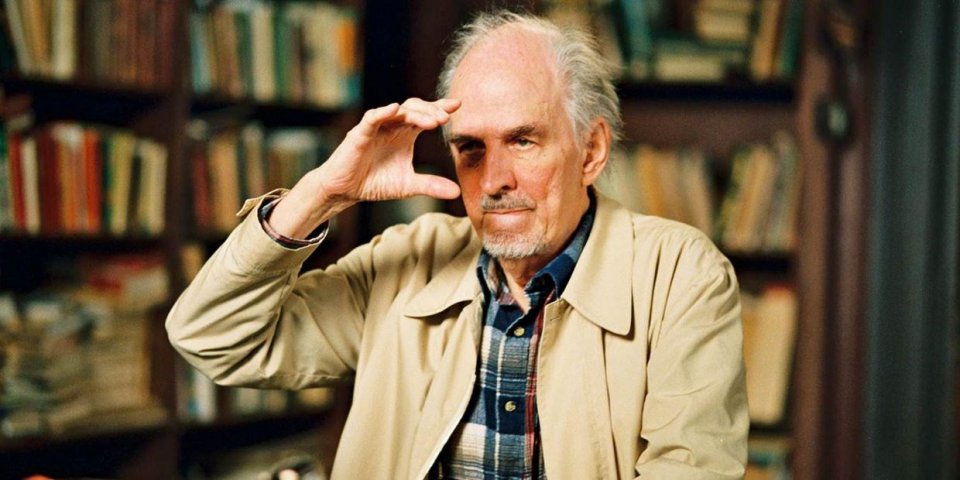
Woody Allen, però, non si limita a queste citazioni riservate al regista svedese, ma fra i suoi due classici del 1977 e del 1979 realizza un intero film ispirato al cinema di Bergman: Interiors, prima pellicola di genere drammatico firmata da Allen, un'opera bergmaniana a ventiquattro carati che dal cinema dell'adorato Ingmar prende a prestito a piene mani temi e suggestioni. Una testimonianza non solo dell'ammirazione viscerale nutrita dal cineasta newyorkese per il suo collega europeo, ma anche del ruolo di primissimo piano di Ingmar Bergman all'interno del panorama culturale di quegli anni.
Leggi anche: Buon compleanno Woody! Il cinema di Woody Allen in 20 scene cult
La lanterna magica di Ingmar

E non è certo un'impresa da poco sintetizzare la densità e il valore dell'insieme della sua produzione: caratterizzato da una prolificità più unica che rara, il regista nato a Uppsala ha firmato nel corso della propria carriera quarantatré lungometraggi per il cinema, sedici film per la televisione, sei cortometraggi e almeno un centinaio di regie per il teatro e la lirica, a cui si aggiungono numerose regie radiofoniche e oltre una dozzina di sceneggiature che sarebbero poi state adattate da altri cineasti. Ma al di là della vastità della sua opera, la ricchezza dell'eredità di Ingmar Bergman risiede anche e soprattutto nella portata rivoluzionaria di film che hanno segnato l'immaginario cinematografico e culturale di diverse generazioni, oltre a costituire modelli di riferimento per registi del calibro di François Truffaut, Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky, Robert Altman, David Lynch e Krzysztof Kieslowski e, naturalmente, Woody Allen.

E proprio Allen, in un'intervista rilasciata a Time due giorni dopo la scomparsa di Bergman, esprimeva con queste parole la capacità di innovazione del regista svedese: "Ha inventato un vocabolario cinematografico per ciò che voleva dire, qualcosa che non era realmente stato fatto prima di allora. [...] Era il contrario di ciò che si imparava in una scuola di cinema, ma era enormemente efficace e appassionante". In fondo, la prima ragione dello straordinario fascino del cinema di Bergman deriva proprio da questo: dalla forza dirompente con cui i suoi film, spesso influenzati dall'opera di August Strindberg ma ciò nonostante ben lontani dalla nozione di "teatro filmato", hanno abbattuto regole e convenzioni preesistenti, riscrivendone di proprie e imponendo un nuovo 'canone' carico di mistero e di meraviglia. E a un decennio esatto dalla morte di Ingmar Bergman, il 30 luglio 2007 (lo stesso giorno della dipartita di Michelangelo Antonioni), vogliamo tornare a esplorare i segreti ineffabili di quella "lanterna magica" a partire da cinque fra i suoi massimi capolavori...
Leggi anche:
-
Robert Altman: da America oggi a Nashville, 10 capolavori di un regista indimenticabile
-
L'amore e il cinema: ricordando François Truffaut nel trentennale dalla scomparsa
-
I 70 anni di David Lynch: 10 personaggi indimenticabili fra Twin Peaks e Mulholland Drive
Il settimo sigillo: il silenzio di Dio

Sebbene fosse già conosciuto e apprezzato dai futuri esponenti della Nouvelle Vague (Truffaut e Godard erano rimasti entrambi folgorati da Monica e il desiderio), per Ingmar Bergman la notorietà internazionale arrivò soltanto dopo un decennio di attività: al Festival di Cannes del 1956, la commedia corale Sorrisi di una notte d'estate vince un riconoscimento speciale e verrà poi distribuita in tutto il mondo; al Festival del 1957, invece, Il settimo sigillo conquista il Premio della Giuria e consacra definitivamente Bergman fra i nuovi maestri del cinema. L'opera più iconica nella produzione del regista (che si basò sulla propria pièce teatrale Pittura su legno), Il settimo sigillo introduce uno dei temi al cuore della poetica bergmaniana: il tormentato rapporto fra l'essere umano e la trascendenza. Un rapporto unilaterale, in cui agli angosciosi dilemmi da cui è afflitto il cavaliere Antonius Block (uno degli attori feticcio di Bergman, il grande Max von Sydow), di ritorno dalle Crociate in una Svezia devastata dalla pestilenza, corrisponde l'ostinato "silenzio di Dio", l'imperscrutabilità del divino.

Perché non posso uccidere Dio in me stesso? Perché continua a vivere in me, sia pure in modo vergognoso e umiliante, anche se io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E perché, nonostante tutto, egli continua a essere uno struggente richiamo di cui non riesco a liberarmi?

La potenza de Il settimo sigillo, tale da renderlo già all'epoca un film di culto (chi non ricorda l'impressionante "danza macabra" dell'ultima sequenza?), risiede in particolare nel modo in cui Bergman recupera un vasto immaginario medievale, assieme alla commistione fra simboli cristiani e pagani, per dare rappresentazione ai drammi dei suoi personaggi: un'operazione analoga a quella effettuata nel 1960 con un'altra pellicola di ambientazione medievale, La fontana della vergine (premio Oscar come miglior film straniero). Ne Il settimo sigillo, dunque, Bergman narra la contrapposizione tra la sofferenza insensata di uno scenario semi-apocalittico, dominato dalla tenebrosa sagoma della Morte (Bengt Ekerot) che sfida Antonius Block a una partita a scacchi, e il vitalismo espresso da un'umile famiglia di saltimbanchi, rendendo il circo, e per estensione la magia dello spettacolo, un indispensabile baluardo contro l'umana disperazione. Il tema del "silenzio di Dio" sarà poi ripreso e approfondito da Ingmar Bergman, fra il 1960 e il 1963, con la trilogia composta da Come in uno specchio (il suo secondo premio Oscar per il miglior film straniero), Luci d'inverno e Il silenzio.
Leggi anche: Quando l'Oscar non parla inglese: da Isabelle Huppert a Mastroianni e la Loren
Il posto delle fragole: fra memoria e sogno

A pochi mesi di distanza da Il settimo sigillo, Ingmar Bergman firma un'altra pellicola epocale, destinata a un'immediata canonizzazione: Il posto delle fragole, che otterrà l'Orso d'Oro come miglior film al Festival di Berlino 1959 e il Golden Globe come miglior film straniero. Attorno al suo attore principale, un magnifico Victor Sjöström, Bergman costruisce il personaggio di Isak Borg, un illustre professore di medicina in procinto di ricevere un'importante onoreficenza; nel corso di un viaggio in automobile verso l'Università di Lund, in compagnia della nuora Marianne (Ingrid Thulin), Isak si troverà a ripercorrere alcuni episodi della propria vita e a sottoporre se stesso a un impietoso bilancio esistenziale. Il confronto fra le generazioni e i conflitti in ambito familiare e coniugale saranno elementi ricorrenti della filmografia bergmaniana, in primis in titoli quali Scene da un matrimonio e Sinfonia d'autunno, ma ne Il posto delle fragole Bergman opta per un approccio narrativo decisamente originale, innervando il realismo delle sequenze del viaggio con le parentesi oniriche del protagonista.
Non sente il silenzio che c'è? Una perfetta operazione chirurgica. Ogni cosa è stata asportata: più niente che dolga, più niente che sanguini o palpiti...

La riflessione del professor Borg sui rimpianti, sull'egoismo e sulla solitudine, veicolata anche dall'incontro con gli 'ospiti' accolti nel proprio veicolo (una ragazza accompagnata da due corteggiatori e una coppia di coniugi in crisi), viene tradotta infatti da Bergman mediante i sogni dell'anziano Isak: dall'idillio romantico del "posto delle fragole", scenario di passioni giovanili, alle opprimenti visioni di morte in cui il regista dà libero sfogo a un accentuato espressionismo visivo. Ne Il posto delle fragole trovano dunque spazio accenti di inesorabile cupezza (gli incubi mortiferi del professor Borg), ma anche momenti di cristallina armonia, fino al rasserenante sentimento di pacificazione di cui è pervaso l'epilogo, con l'affettuoso commiato di Sara (Bibi Andersson) e dei suoi due amici e la prospettiva di un sonno finalmente libero dalle ombre del passato.
Persona: faccia a faccia

Se i film di Ingmar Bergman si erano spesso trovati sospesi fra il naturalismo e il sogno, nel 1966 Persona segna una brusca virata verso i territori del surreale del visionario, spingendo il cinema del regista svedese lungo un percorso di sperimentalismo ancora più spiazzante e radicale. In precedenza Bergman aveva già realizzato alcune pellicole interamente costruite sul confronto fra personaggi femminili (Donne in attesa, Alle soglie della vita), ma l'effetto dirompente di un'opera come Persona ha ben pochi eguali negli annali del cinema. L'intero film è imperniato sul rapporto fra Elisabeth Vogler (Liv Ullmann), un'attrice che si è rinchiusa in un improvviso mutismo, e Alma (Bibi Andersson), la giovane infermiera che la accompagna in una solitaria casa in riva al mare per prendersi cura di lei: l'inviolabile afasia di Elisabeth e le confessioni a cuore aperto di Alma, compreso il suo rimorso per aver preso parte a un'orgia, daranno inizio a un "faccia a faccia" sviluppato come un lungo monologo da parte di Alma, in un superbo duetto recitativo che corrisponde pure al primo tassello del sodalizio (professionale e privato) fra Bergman e la Ullmann.
Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento: tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile, e nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero?

Nel gioco di specchi fra l'ermetica Elisabeth e la più fragile e insicura Alma, impegnate di volta in volta a indossare e far cadere le rispettive maschere, il regista inserisce una miriade di ulteriori suggestioni, anche e soprattutto sul piano visivo e simbolico: a partire dal memorabile incipit, una folgorante macrosequenza che sembra partorita dall'inconscio delle protagoniste, con echi dei canonici temi bergmaniani legati alla religione (la mano inchiodata alla croce e la tarantola, già in Come in uno specchio personificazione di un Dio 'mostruoso'), al sesso (il fotogramma di un pene in erezione) e alla maternità. E ancora, Bergman abbandona progressivamente il realismo della messa in scena per giocare con le immagini, caricando di sfumature ambigue i volti delle due donne: volti che si cercano, che si sfiorano, che si incrociano e si sovrappongono all'interno dell'inquadratura, fino a compenetrarsi letteralmente l'uno nell'altro.

Opera rivoluzionaria e dal fascino intramontabile, Persona costituisce l'inizio e al contempo il vertice di un nuovo capitolo onirico e allucinato della filmografia bergmaniana: un capitolo che proseguirà con l'esperimento quasi horror de L'ora del lupo, così come, un decennio più tardi, nel viaggio introspettivo de L'immagine allo specchio, altro magistrale tour de force di Liv Ullmann. Mentre è probabile che, senza Persona, non avremmo avuto (o perlomeno non come le conosciamo oggi) pellicole quali Tre donne di Altman e Mulholland Drive di Lynch.
Leggi anche: Mulholland Drive: è davvero il miglior film del 21esimo secolo?
Sussurri e grida: il colore dell'anima

È un altro dramma quasi interamente al femminile, Sussurri e grida, a rappresentare nel 1972 un altro vertice assoluto dell'itinerario cinematografico di Ingmar Bergman, nonché uno dei suoi maggiori successi internazionali. Proiettato fuori concorso al Festival di Cannes 1973, Sussurri e grida riceve cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior film e regia, e si aggiudica il premio per la stupenda fotografia di Sven Nykvist, fedele collaboratore di Bergman, che per l'occasione passa dal bianco e nero delle opere precedenti al colore: un colore la cui massiccia saturazione trasforma gli ambienti del film, un'antica dimora di campagna, in un luogo dai contorni simbolici (il rosso intenso delle scenografie sarà definito da Bergman come "l'interno dell'anima"), teatro di una liturgia funebre celebrata attorno alla figura di Agnes (Harriet Andersson), affetta da un male incurabile.

Le persone che amavo più di tutte al mondo erano lì: potevo udirle chiacchierare intorno a me, sentivo la presenza dei loro corpi, il calore delle loro mani. Volevo aggrapparmi a quel momento, e pensai: 'Qualunque cosa accada, questa è la felicità: non posso desiderare niente di più'.

L'attesa della dipartita di Agnes è scandita dalle storie personali delle sue due sorelle, tra flashback, sogni e allucinazioni: Maria (Liv Ullmann), contraddistinta dall'egoismo e dall'indifferenza, e Karin (Ingrid Thulin), che nella scena più scioccante del film (e una delle più 'scandalose' di tutto il repertorio di Bergman) si infligge una mutilazione genitale, per poi cospargersi il volto di sangue vaginale di fronte all'algido marito. Opera tanto estrema quanto ricca di spunti e possibilità di lettura, Sussurri e grida rimane un'altra pietra miliare nella produzione del regista, oltre che uno dei suoi film più personali e coinvolgenti.
Fanny e Alexander: padri e figli (e fantasmi)

"Tutto può accadere, tutto è possibile e verosimile. Il tempo e lo spazio non esistono. Su una base insignificante di realtà, l'immaginazione fila e tesse nuovi disegni": sono le parole di August Strindberg, dal dramma Il sogno, a fare da suggello all'ultimo lungometraggio cinematografico di Ingmar Bergman. Distribuito nelle sale svedesi nel dicembre 1982, in una versione di tre ore di durata, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 1983 e trasmesso anche sul piccolo schermo in un'edizione di oltre cinque ore, Fanny e Alexander è l'inestimabile testamento artistico di Bergman (il quale tuttavia continuerà a girare pellicole per la televisione fino al 2003, con Sarabanda) e uno dei suoi progetti più ambiziosi, nonché di quelli di maggior successo: accolto come l'ennesimo capolavoro del regista, Fanny e Alexander viene ricompensato con un Golden Globe e quattro premi Oscar per il miglior film straniero, la fotografia, la scenografia e i costumi.

La vita è fatta così: è per questo che dobbiamo essere felici quando siamo felici, ed essere gentili, generosi, teneri, buoni... proprio per questo motivo è necessario, e tutt'altro che vergognoso, essere felici, gioire di questo piccolo mondo.

Dall'atmosfera gioiosa e confortevole della notte di Natale del 1907, ad Uppsala, il film si dipana attraverso lo sguardo del piccolo Alexander Ekdahl (Bertil Guve), testimone e protagonista delle traversie che faranno seguito alla morte di suo padre, il teatrante Oscar (Allan Edwall), e alle seconde nozze della madre Emilie (Ewa Fröling) con il tirannico pastore Edvard Vergérus (Jan Malmsjö). Rutilante cronaca familiare, Fanny e Alexander esprime il legame conflittuale con una figura paterna scissa in due opposte declinazioni: l'affetto per il padre naturale, il quale incarna l'attrazione di Alexander per il palcoscenico (la prima sequenza si apre non a caso su un teatrino giocattolo), e il sentimento di timore e di ribellione verso il padre putativo, alfiere di un opprimente autoritarismo religioso che vorrebbe soffocare ogni traccia di fantasia. Assumendo il punto di vista di un ragazzo aperto al mistero e alla meraviglia, Bergman celebra il potere salvifico dell'immaginazione e dell'arte realizzando un'opera avvolgente e funambolica, in cui la voce di Dio sembra parlare tramite inquietanti marionette mentre la realtà è popolata da presenze/assenze che assumono forma di ricordi (le fotografie di nonna Helena) o di fantasmi di cui non sarà mai possibile liberarsi del tutto.