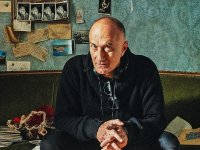Dopo il passaggio in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Mostro, serie Netflix diretta da Stefano Sollima, è a disposizione del pubblico che potrà gustarsela sul divano di casa. "Ma speriamo che non la guardino sul cellulare" ci dicono i nostri quattro interlocutori su Zoom, ovvero Marco Bullitta, Valentino Mannias, Giacomo Fadda e Antonio Tintis, i quattro attori che interpretano i mostri, quelli che di volta in volta la serie mette al centro dell'attenzione come potenziale colpevole in una costruzione episodica ragionata e riuscita. Perché è vero che si tratta di una serie pensata per Netflix e lo streaming, ma è ugualmente vero che sia noi che loro siamo stati fortunati: l'abbiamo potuto guardare su grande schermo in un contesto che mette il cinema al centro, senza che ne uscisse penalizzata ma piuttosto valorizzata.

E in quel contesto sala, la serie di Sollima emerge in tutta la sua intensità e potenza, in tutta la sua cura visiva, quindi inevitabile un appello a guardarla nel modo migliore possibile e non accontentarsi dello schermo ridotto di uno smartphone: "il fatto di guardare fuori casa e su ogni dispositivo è qualcosa che ha avvantaggiato ma anche penalizzato tanti prodotti di ottima fattura a livello di fotografia e dettagli" ci ha detto Marco Bulletta, che nella serie interpreta Stefano Mele, marito di Barbara Locci, tra le prime vittime del Mostro.
L'invito che condividiamo, quindi, è di guardare la serie su un dispositivo di buon livello e delle giuste dimensioni, per apprezzare "soprattutto il lavoro di Carnera, un maestro per quanto riguarda la fotografia" come ci suggerisce Giacomo Fadda, che interpreta invece Francesco Vinci, un altro dei nomi coinvolti nella cosiddetta Pista Sarda che la serie Netflix ci fa scoprire o approfondire sfruttando la natura episodica per cambiare punto di vista e mettere al centro un potenziale Mostro dopo l'altro.
Un punto su cui si sofferma anche Antonio Tintis, che dà il volto a Giovanni Mele: "Noi l'abbiamo visto una puntata dietro l'altra, e anche su Netflix me le divoro le serie, ma altri vedranno una puntata, poi pausa, poi vedranno la seconda e così via, questo potrebbe dare anche più valore al lavoro fatto, sia di scrittura che di costruzione delle puntate, perché ogni episodio ha una caratteristica sua, particolare, che magari vedendole tutte insieme un po' si diluisce." La forza della vecchia serialità, che permetteva di approfondire e ragionare, che potrebbe essere applicata alla visione, o una seconda visione dopo averla divorata al primo giro, de Il Mostro.
La struttura episodica era chiara sin da quando eravate sul set?
Giacomo Fadda: Sì, assolutamente, nel senso che era chiaro che ognuno di noi avesse un piccolo universo a parte con qualche ponte che ci collegava. Anche fisicamente era così quando ci incontravamo al campo basso con gli altri prima di girare.
Marco Bullitta: Infatti parte della difficoltà del lavoro era ricomporre noi stessi i pezzi del puzzle, dire ok ora sto facendo questa scena, ma in che universo mi trovo? Sono nell'universo Salvatore Vinci o nell'universo Mele? Quindi si percepiva ed era parte del lavoro.
Antonio Tintis: Ognuno riportava una mostruosità diversa dall'altro, infatti ero molto curioso di vedere la serie lì a Venezia, perché volevo vedere i mondi degli altri tre mostri, pensando sempre che il mio fosse quello un po' più grottesco rispetto agli altri.

Valentino Mannias: Come dicevi anche tu prima, è una cosa vincente perché in qualche modo chiede allo spettatore una presa di responsabilità. La puoi vedere da varie prospettive, ma se vuoi avere un approccio complottista o che sposa una tesi, subito sei fuori gioco, nel senso che la serie ti propone una complessità. Se vuoi entrare in questa complessità è più "divertente", tra virgolette, più affascinante. Anche quando parlavamo con Cappelletti, il Mostrologo che ci ha aiutato, una delle cose che mi ha colpito, che ci ha colpito, di più, è stata che a parlare con lui, quando eravamo nella fase in cui eravamo tipi criminologi, ci ha detto che in realtà le ha studiate tutte e ogni volta, per ogni certezza che aveva, doveva fare tre passi indietro. Questo perché nessuna l'ha veramente soddisfatto e questa credo che sia la ragione per cui trovi forte questa scelta interpretativa, perché rispecchia la realtà poi delle indagini. E questo credo sia un tema anche del nostro tempo: non c'è mai una verità, ma è come tu la interpreti.
Nei diversi episodi vediamo alcuni momenti da diversi punti di vista. Come ci avete lavorato?

Giacomo Fadda: Era diviso più che altro a tranche di location. Penso a scene come l'omicidio Lo Bianco e ricordo casi in cui nella stessa location ho fatto una scena io, poi l'ha fatta Valentino. Ci siamo passati il testimone. Ci incrociavamo proprio nelle location, quindi il punto di vista si incrocia proprio in questo punto della lavorazione. I ponti erano proprio le location: la casa di Stefano Mele e di Barbara Locci, oppure il luogo del primo omicidio di Antonio Lo Bianco/Locci, erano delle location in cui, a livello di sceneggiatura e di lavorazione, si costruivano i ponti tra le nostre quattro storie. Quindi alcune sequenze che si ripetono più volte in più episodi, magari le abbiamo girate nell'arco di una settimana, pochi giorni.
Che tipo di lavoro avete fatto per indagare i vostri personaggi insieme al Mostrologo?
Valentina Mannias: Due cose mi vengono in mente. Una è che chiaramente già in fase di studio le fonti si dividevano qualitativamente in due tipologie: gli uni erano quelli che volevano dare una verità con il loro testo, con la loro scrittura, e gli altri erano quelli che cercavano di non farlo troppo, stando sugli atti della scientifica e sugli atti dei processi. A me sono servite entrambe. Prima di tutto la seconda, come importanza, che è più obiettiva. Ma c'è anche bisogno di qualcuno che te la romanza per immaginarti una biografia, una psicologia. E poi un aspetto di base come atteggiamento deontologico è stato non pensare di dover interpretare un mostro. Perché in qualche modo quell'orrore, quella violenza, sentivo che mi stimolava di più come qualcosa da riconoscere dentro di me per poi comunicarla fuori. E credo che sia un po' per tutti così, anche che ci piaccia o no. Poi, chiaramente, come società facciamo l'opposto per stigmatizzare e allontanarci. Da piccoli lo chiamiamo il lupo e da grandi lo chiamiamo il mostro. Però non è un approccio che per interpretare arricchisce, quello di dare un giudizio sul proprio personaggio, piuttosto il contrario.

Giacomo Fadda: Collegandomi a quello che ha detto Valentino sul giudizio, per me è stato quasi una cosa fisiologica, naturale, perché tutto è iniziato dai provini. Nel senso che abbiamo fatto tantissimi provini in cui mi incrociavo in particolar modo con Valentino, ma non sapevamo che erano i provini de Il Mostro. Mano a mano, c'era sempre una nozione in più dal punto di vista umano e psicologico del personaggio. Io non sapevo assolutamente che stavo facendo i provini per Francesco Vinci, ma per un ragazzo molto innamorato di una donna in difficoltà, con un fratello molto particolare. Poi, piano piano, si aggiungeva la nozione della gelosia, poi quella della brutalità, fino a poi ad arrivare al Mostro di Firenze. Ma prima di arrivarci c'erano tutti gli elementi che ci davano le casting director, Laura Muccino e Sana Casani, e poi anche Stefano Sollima, perché anche lui è entrato nel processo di casting dai primi callback. Questo mi ha imposto di fare proprio quello che stava dicendo Valentino: non intellettualizzare il personaggio, dargli una qualità prima ancora di capire chi fosse. Quindi per me i provini sono stati fondamentali.
Antonio Tintis: Io forse sono quello che aveva meno materiale, perché su Giovanni Mele c'è un po' meno rispetto agli altri. Anche fisicamente sono decisamente diverso da Giovanni Mele e questo per certi versi mi ha aiutato, perché ovvio ho letto tanto, non conoscendo niente io della Pista Sarda così come penso gran parte del pubblico. Mi sono preoccupato più di capire come funziona l'elemento Giovanni Mele all'interno di quella scrittura di quell'ambiente, di quell'Italia di quel periodo lì, prendendo appunto la distanza dal personaggio reale e portando il rispetto a tutta la storia, ma avendo anche la libertà di distanziarmene, appoggiandomi e avendo fiducia della scrittura di Leonardo e di Stefano, che portava tante problematiche da affrontare.

Marco Bullitta: Per quanto mi riguarda la maggior fortuna è che c'era un'ottima scrittura dei personaggi. Ed essendo personaggi realmente esistiti, grazie alla documentazione, grazie a libri sul tema, ho avuto la fortuna di trovare molto materiale su Stefano Mele. Quindi ho potuto ricostruire, ho potuto rileggere la sua biografia, come è vissuto, da che contesto arrivava che era quello di una famiglia molto patriarcale. Una Sardegna fuori dalla Sardegna, ma comunque chiusa e sigillata in questo piccolo mondo da cui non voleva e non riusciva a uscire. Una sorta di immigrazione andata male, che non ha funzionato, come spesso succede anche nei gruppi etnici che abitano in nuove città. Ho avuto la possibilità di ricostruire un po' tutta la sua personalità per poi utilizzarla e fonderla facendo un lavoro come un puzzle.
Tra fedeltà ai fatti e rispetto per le vittime, c'era un limite autoimposto?
Antonio Tintis: Il limite lo dava la precisione, l'attenzione al dettaglio, l'attenzione a quello che si doveva fare. Ad esempio sugli omicidi c'era Francesco Cappelletti, c'era Stefano, c'erano gli stunt, abbiamo fatto delle prove prima e c'era l'attenzione maniacale a non inventarsi niente e a stare attenti, avere cura di quello che si stava facendo, perché veniva da una realtà. Tutti siamo stati nel primo periodo a provare i costumi, dentro una saletta a Cinecittà piena di foto orribili. Io mi ricordo una delle prime volte, lì mezzo nudo, da solo perché sono usciti e dovevamo prendere dei pezzi, e lì ho capito che dovevo portare anche io un certo tipo di rispetto. Il rispetto non è una cosa emotiva, perché l'emozione ci sta sempre più rovinando rispetto a tanti argomenti, ma è razionalizzare e dire "io cosa posso fare?". Devo essere rigorosamente crudele, devo essere rigoroso nel mio lavoro, questo è il mio portare rispetto.

Giacomo Fadda: In tutte le scene degli omicidi, il rispetto veniva anche dal punto di vista tecnico, erano delle scene estremamente tecniche. Non si poteva avere la libertà di fare qualsiasi cosa. Qui entra in gioco il ruolo di Cappelletti, perché mi ricordo una foto che ci ha mostrato prima di una delle scene degli omicidi, dove c'erano i resti di Migliorini e Mainardi, proprio appena li hanno trovati: sono delle foto che ti portano un'energia e ti alimentano durante tutta la scena. Tutte queste energie, anche negative, sono tutto un turbine che ti portano al rispetto automatico. Anche il fatto che queste scene sono estremamente realistiche contribuisce. Mi ricordo una volta tornando dal set, mi giravo indietro per capire se ci fosse qualche entità malefica. Non so se vi è mai successo da piccoli, ma mi è successo dopo che giravamo queste scene, perché la cura nel dettaglio e il rispetto per quelle situazioni portavano ad un realismo che ti obbligava a comportarti di conseguenza.
Valentino Mannias: Il rispetto è una parola che immediatamente ne richiamo un'altra: precisione. Prima del set non so perché ho avuto questo approccio un po' ossessivo a casa: avevo ricostruito la scena del crimine con i nastri per le dimensioni della macchina e le foto dei morti reali e quelle immagini, quelle facce quando ti guardavano la notte durante le prove, qualcosa la fanno. L'artigianato del set nella sua finzione, che è un'altra parola importante che ti richiama una distanza necessaria anche da prendere, aiutava in qualche modo a sublimare e a raccontare questa storia.

Un'altra cosa che ho apprezzato di Stefano nel modo di lavorare è il realismo fino a un certo punto, nel senso che per raccontare qualcosa di veramente angosciante, a volte è controproducente andare oltre, vedere troppo. Mi viene in mente il Conte Ugolino, noi non sappiamo se lui abbia mangiato davvero o no i suoi figli per Dante. "Più che 'l dolor, poté 'l digiuno", è assolutamente un verso ambiguo, non so se se li hai mangiati o no. In certe scene che abbiamo girato tu vedi dei dettagli che te ne fanno immaginare degli altri e tutta la storia funziona un po' così: quello che ti colpisce sono le escissioni e la crudeltà di quei momenti, ma soprattutto il fatto che non abbiano un volto, che alleggi un'ambiguità, ed è lì che in qualche modo si crea uno specchio con noi, perché il mostro potrebbe essere chiunque. Ecco questo credo che sia l'elemento più angosciante, anche con quello che si sente tutti i giorni, che probabilmente questa persona non era del tutto emarginata socialmente.
Marco Bullitta: Poi questo è anche il periodo migliore per evitare delle spettacolarizzazioni, riguardo il rispetto. Non c'è un periodo più florido, più ricco di immagini strazianti, di violenza e penso che proprio questa sia la forza di questo prodotto: andare a non spettacolarizzare quell'aspetto di cui puoi leggere, puoi avere materiale fotografico su internet. Oggi è facilissimo vedere una persona decapitata sul cellulare e questo è secondo me il momento migliore per andare a cercare un nuovo punto di vista.
Antonio Tintis: Siamo ben lontani dalla pornografia del dolore che ci sta attanagliando.
Che percezione della storia del Mostro avevate prima di questo lavoro e come ne uscite?
Marco Bullitta: Io ho giusto una considerazione personale: il Mostro di Firenze è la Marylin Monroe di Andy Warhol per la cultura del crime in Italia, e non ha mai vissuto un momento in cui non se ne parlasse, non ci fosse ancora qualcosa da indagare. Le indagini sono durate quasi 20 anni, ma non hanno mai vissuto fino ad oggi un momento di silenzio, di quiete e rimarrà probabilmente per altri 50 anni. Esco da questa serie con l'idea che siamo andati fuori dall'iconografia delle parti conosciute di questa storia, andiamo a vederne un realismo, partiamo dalle origini e ne abbiamo una nuova visione più umana, con delle persone reali e non più, come diceva prima Antonio, questa pornografia legata al mostro.

Antonio Tintis: Il fatto che sia passato così tanto tempo per certi versi può aiutare, questa serie ovviamente non nasce per risolvere niente, ma per ricordare da dove si è iniziato, da dove ha iniziato tutto. Riporto un'esperienza personale: dopo una scena di un omicidio fatta più volte, io sono tornato a casa e mia moglie mi ha detto, "ma che c'hai?" Io mi stavo chiedendo ma com'è possibile? Come diavolo è stato possibile?
Tutti questi omicidi, tutta quest'omertà, tutti questi errori, come diavolo è stato possibile? Ecco, riportare un punto di domanda sarebbe già un bel punto a favore della serie e dell'operazione che ha voluto fare Stefano. Farsi delle domande, non dare delle risposte per etichettare questo o quell'altro, per etichettare adesso i Sardi, come si è etichettato Pacciani, Vanni, i compagni di merenda e tutto il resto. È importante questo, è quasi una risposta culturale. Come attori siamo degli operatori sociali, dobbiamo portare cultura, ma cultura è pensiero, non è nozionismo, e quindi un approccio culturale rispetto a una vicenda del genere, secondo me è sano.
Giacomo Fadda: Io della storia del mostro di Firenze, prima di questo progetto, sapevo solo tre cose. Sapevo che ammazzava delle coppie attorno alla città di Firenze e che era Pacciani, perché avevo questa convinzione prima della serie; sapevo che la prima vittima era Sarda, ma non conoscevo la Pista Sarda; e poi che i miei genitori non sono andati a Firenze in viaggio, perché c'era questo serial killer che ammazzava proprio le coppie. Sapevo soltanto questo e sono fiero che grazie a questo progetto ho conosciuto tante altre cose, fiero di averlo fatto con loro innanzitutto, con Marco, Valentino e Antonio, fiero di averlo fatto con Stefano, con Capelletti e con tutto lo staff. Ma la cosa che mi rimane da questo progetto è proprio il luogo in cui questi più giovani sono stati ammazzati. Penso che sia la cosa che più mi ha segnato rispetto a quello che sapevo prima della storia del mostro di Firenze.

Valentino Mannias: Prima di affrontare questo progetto anch'io, come tutti, ero un po' vittima di quella che era la comunicazione mainstream, la pista fiorentina, le banalizzazioni del caso, l'immagine che effettivamente si è stagliata in immaginario comune per troppi anni. Esco da questa storia conoscendo una complessità maggiore: Una storia non risolta, e penso che proprio questa sospensione sia la parte che ci rispecchia di più, perché quegli anni lì, dagli anni 60 in poi, sono stati gli anni in cui culturalmente avevamo iniziato a mettere polvere sotto il tappeto, facendo finta di diventare una società moderna e in realtà ereditando ancora uno schema patriarcale nelle nostre relazioni quotidiane, delle dinamiche di potere che vediamo ancora oggi.
Diciamo che dopo che l'ho vista a Venezia, quello che mi ha fatto più contento è stato proprio questo: il cazzotto in pancia che questa serie dà sul presente, laddove non te l'aspetti perché dici "guardo una storia vera, adesso sul mostro mi diranno chi è il colpevole" e invece no, invece ci sei tu, le cose brutte della tua cultura che la propaganda mainstream cerca di nasconderti. E su questo, come diceva prima Antonio, sono stato proprio contento perché sono quelle rare volte in cui da attore dici "ho fatto proprio il mio mestiere, questo dovrei fare nella vita, questo sarebbe il mio mestiere, non intrattenimento". Quello che mi è proprio venuto in mente dopo averla guardata è che questo non è un qualcosa che ti intrattiene tra un evento A importante e un evento B importante, è un qualcosa che ho proprio sentito è che credo sia una serie che ti cambia dopo che la vedi, che ti lasci un segno, e questo mi ha fatto essere soddisfatto.